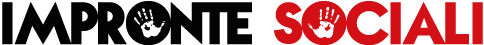I valori della Resistenza. In occasione del 25 aprile, giorno della Liberazione, in cui si ricorda l’eroico sacrificio di partigiani e cittadini contro l’oppressione nazifascista, pubblichiamo l’articolo “Il dialogo tra generazioni come trasmissione dei valori fondamentali” di Domenico Modola, vincitore della Menzione Speciale al Premio Giornalistico “Giovanni Sarubbi” con la seguente motivazione: “per la chiarezza con cui l’autore espone le potenzialità del dialogo tra giovani e anziani, e dei valori come il tempo e la volontà che sono fondamentali per la costruzione del dialogo intergenerazionale”.
Il dialogo tra generazioni come trasmissione dei valori fondamentali
Come si gestisce il rapporto tra le vecchie glorie e le giovani promesse è un argomento che tiene da sempre banco. Lo chiamano dialogo intergenerazionale, e sono in molti a pensare che questo sia quantomai necessario per trasmettere ai giovani, l’intero tesoro valoriale, in cui gli anziani hanno creduto e per cui hanno lottato da giovani. Si tratta di trasmettere due elementi fondamentali: conoscenza e memoria. Partire dal passato per favorire lo stimolo del progresso. Certo, è risaputo, il dialogo tra le due fasce d’età non è per nulla facile, ostacolato dai soliti stigmi secondo cui “i giovani di oggi non ascoltano” e “i vecchi sono convinti di sapere tutto”, però quando le due parti in causa si incontrano, possono dar vita a qualcosa di interessante che può avere addirittura una valida funzione per la costruzione di una società del futuro.
In sostanza, il dialogo intergenerazionale può essere utile ad entrambe le parti, purché non sia un dialogo limitato solo all’ambito prettamente domestico, in cui l’anziano è utile al giovane solo quando a quest’ultimo serve un consiglio su questioni di casa o per la ricetta particolarmente saporita, che solo la nonna sa fare. Invece il dialogo dev’essere improntato alla gestione di quelli che sono i principi su cui si è edificata la nostra società e come fare per migliorarli e renderli effettivi.
Oggi, forse più che in altre epoche storiche, pare che si assista ad una deriva valoriale e forse, la generazione dei “millenials”, ben consapevole delle difficoltà di trovare affermazione nel futuro, tende maggiormente a fare muro contro le generazioni più mature; di contro, anche quest’ultime tendono ad etichettare negativamente i più giovani, dimenticando che forse, gli atteggiamenti “poco etici” di cui si sente spesso parlare sono più ciclici che ad esclusivo appannaggio dei tempi moderni. Il dialogo tra generazioni incontra numerosi ostacoli, è vero: l’incomunicabilità dovuta al progresso tecnologico, i mutamenti linguistici, le esigenze di una società in trasformazione.
Tutti elementi che infondono l’idea che nella società attuale sia venuto meno lo spirito di convivenza e di spazio comune: ognuno arraffa ciò che può, appena può. Così facendo, le due generazioni, anziché confrontarsi e dialogare, restano appollaiate su barricate fatte di incomprensioni e screzi, lasciando in mezzo un gap che può essere colmato solo dalla trasmissione della ricchezza generata dall’esperienza e dai principi.
Il dialogo come fondamento dello sviluppo della persona
integrato in cui fattori innati vengono influenzati da fattori esterni dovuti all’esperienza e viceversa. Gli aspetti biologici predispongono l’interazione e le modalità in cui essa avviene, il resto lo si apprende dall’ambiente circostante e dalle interazioni con altre persone. Le esperienze, quindi, contribuiscono in larga misura alla formazione della personalità.
Da ciò deriva che le relazioni intergenerazionali, assumono importanza fondamentali tra tutte quelle che riguardano i rapporti tra esseri umani, specie in una società che attualmente si presenta estremamente frammentata e le cui generazioni appaiono nettamente suddivise in classi d’età. L’aspetto che assume la società in questi termini però, priva le generazioni di un incontro che in realtà dovrebbe essere più naturale e logico di quanto si possa pensare; un incontro che apparteneva al quotidiano soltanto alcuni anni fa, ma con l’atomizzazione di cui è sempre più pregno il contesto attuale, questa normalità è venuta meno.
La relazione che si andrebbe ad instaurare tra adulti e bambini o tra nonni e nipoti, va valutata nell’ottica di un’esperienza di incontro e di superamento di distanze che, a conti fatti sono temporali, esistenziali, ma anche sociali e culturali. Vivere tale relazione può significare letteralmente abbattere questa distanza. Tuttavia, la relazione che andrebbe ad instaurarsi, può aver luogo solo se avviene liberamente e non mediante un momento meccanico. L’autenticità viene garantita solo se le due parti entrano in contatto liberamente, come se dessero vita ad un momento di ricerca e scoperta reciproca.
Dialogo intergenerazionale e storia: l’importanza delle generazioni passate
La storia è una disciplina che solitamente appassiona in pochi negli anni della scuola. Le date, i nomi dei personaggi storici, i luoghi sconosciuti; tutte cose che vengono percepite come lontane e inconcepibili dai giovani che raggiungono ogni tipo di informazione con semplici gesti sullo smartphone. Forse perché la storia, per logiche d’insegnamento e per dovizia di tempi didattici, viene spiegata in fretta e furia, lasciando ampio spazio solo agli eventi più salienti. Tuttavia è proprio nei dettagli che si trovano i risvolti più interessanti che possono catturare maggiormente l’attenzione. Rendere la storia più “comprensibile” può aiutare a comprenderla.
Momenti come la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza dei Partigiani, cosa spinse quei giovani ad andare sulle montagne a combattere i nazisti, l’importanza del 25 aprile; sono episodi che forse sono ancora recuperabili in termini di reperibilità di fonti atipiche. Intervistare l’anziano del paese, o chiedere al nonno di raccontare la propria esperienza di guerra ad esempio, può essere un buon inizio. Discorso analogo si può fare per comprendere meglio gli anni di piombo o il fenomeno dei matrimoni per procura, il boom economico degli anni ’60 ecc. In questo particolare aspetto, un ruolo determinante potrebbero giocarlo i docenti, che potrebbero stimolare in tal senso, per fini didattici, il dialogo tra gli studenti e la generazione più anziana, facendoli dialogare con i nonni o con i genitori. Così facendo si stimolerebbe di gran lunga un dialogo con risultati proficui per il giovane, ma anche per lo sviluppo e la preservazione della memoria collettiva.
Anche che se la fattibilità di questo aspetto può sembrare facile solo a parole, in realtà vi sono buoni spiragli che lasciano ben sperare. Ad esempio i religiosi si esprimono con ottimismo riguardo il dialogo tra generazioni, il quale starebbe, secondo il loro punto di vista, vivendo una nuova fase di riavvicinamento. In fin dei conti, il discorso regge, se si considerano le generazioni come legate ad un filo, che è rappresentato appunto dai valori e dalla rappresentazione di essi.
Se si considera il contesto dal punto di vista internazionale, il quadro appare ancora più chiaro; le statistiche riportano un progressivo inasprirsi delle misure repressive della libertà d’espressione da parte delle autorità in varie parti del mondo; sempre più persone, secondo i dati, vivono sottoposte a regimi autoritari o simil-dittatoriali; un aspetto che in poco tempo ha bruciato decenni di lotte per la libertà e la democrazia, tenute in piedi appunto, dalle generazioni precedenti. Il fragile filo che lega le due generazioni, in Italia come in America Latina, come nel Nord Europa o come oggi ad Hong Kong, in Algeria ecc., è rappresentato in questo caso dai giovani che scendono in piazza e difendono i valori che i padri o i nonni hanno ottenuto lottando con tutte le forze. Finché avrà vita questa fiamma, il dialogo sarà altrettanto vivo, ma soprattutto costruttivo. Quindi se oggi si è affermata una concezione della storia, considerata come statica, l’intervento deve puntare al ripristino della concezione della storia come evoluzione.
Incomprensioni: le difficoltà dei giovani
Cosa chiedono i giovani? In genere le loro istanze, più o meno esplicite sono le seguenti: umiltà, fiducia, accettazione dell’altro così come è, coerenza di vita, autenticità e flessibilità allo stesso tempo, oltre chiaramente a buone prospettive per il futuro. Le incomprensioni che provocano la frattura e l’arroccamento delle due generazioni, nascono da una divergenza di punti di vista, che in realtà è più apparente che reale. Quando tuttavia, questa frattura avviene, risulta complicato addentrarsi nei meandri dell’altra “fazione” per carpirne le difficoltà e cercare di intervenire. Per esempio i giovani e le loro difficoltà. Si dice che da sempre, la generazione precedente non vede di buon occhio quella successiva e che, le difficoltà che i giovani affrontano, non sono insormontabili come sembra, ma sono solo ostacoli commisurati all’età, perché d’altronde “i problemi veri vengono dopo”.
Tuttavia se prendiamo in considerazione i giovani di oggi, le difficoltà ci sono e per certi versi appaiono come inedite ad una o due generazioni precedenti. La formazione continua, la corsa sfrenata e necessaria a titoli di studio sempre più elevati per trovare un lavoro dignitoso, ma anche le esperienze di stage o alternanza-scuola lavoro, rendono più sfumato il periodo tra la fine degli studi e l’ingresso ufficiale nel mondo del lavoro. Come se non bastasse questi primi approcci al mondo del lavoro, fatti di precariato, sfruttamento e mancata valorizzazione della risorsa, formano un giovane già rassegnato ad un futuro iniquo ed ingiusto. Uno stimolo negativo che può instillare uno spirito di rinuncia nel giovane, per quanto riguarda le aspirazioni future. Non è raro infatti, trovare nei millenials, mancanza di prospettive, zero progettualità e la totale incertezza sugli obiettivi da perseguire. In questo contesto, qual è il ruolo delle generazioni precedenti? Sicuramente quello di parenti, comprensivi e consapevoli, non di certo quello di giudici. Il fatto che la nuova generazione non abbia progetti per il futuro è dovuto a fattori esterni all’Io interiore: fattori economici e sociali che inevitabilmente si ripercuotono su aspetti relazionali e psicologici del singolo.
Quindi il compito della generazione più matura è quello di comprendere che l’atteggiamento rinunciatario è dovuto a tali fattori e non ad un senso di svogliatezza a carattere generazionale. Nonostante questo però, l’incomunicabilità e l’isolamento siano insormontabili, anzi; le potenzialità derivanti dal dialogo intergenerazionale hanno un ampio spettro d’azione e possono fungere da volano per la direzione del cambiamento. Certo, perché se si continua a ribadire che i giovani sono il futuro e le cose, qualsiasi cosa, dall’antimafia alla pace, alla Memoria, si costruiscono partendo dall’educazione nelle scuole, il dialogo tra generazioni è la base per la società di domani.
I ventenni d’oggi non sono diversi da quelli del passato. Le differenze sono poche e la facilità di accesso a sistemi di comunicazione, e la maggior possibilità di fruizione di spazio e tempo sono differenze che non cambiano la sostanza. I ventenni del 2022 hanno sogni, ideali e talvolta perseguono libertà, giustizia ed uguaglianza. In modalità diverse, ma sono le stesse cose che a gran voce reclamavano i ventenni che divennero Partigiani o quei ventenni che nel ’68 riempirono le piazze. C’è un clima di sfiducia e rassegnazione, ed è vero, ma le basi sono solide se ci sono sogni e ideali, e da quelli si può ripartire.
Ripristinare il dialogo tra giovani e anziani: prove tecniche di fattibilità
Per favorire l’interscambio di informazioni tra le due generazioni bisogna porre fine all’arrocco. In primo luogo occorre che le due “categorie” si liberino tra pregiudizi, stereotipi e stigmi negativi con cui identificano la generazione opposta. Tale fase può aversi solo mediante un momento di profondo ascolto; ascolto di quelle che sono le istanze dell’una e dell’altra generazione. Farlo una volta che ci si è spogliati da qualsivoglia giudizio aprioristico può essere il primo passo nella direzione giusta, un passo da fare verso l’altro.
Questa modalità infatti, impedisce alle persone più mature di considerarsi più sagge e sottovalutare le competenze dei giovani; d’altro canto, l’ascolto fa sì che i giovani prestino ascolto agli anziani e non li considerino “roba passata”. D’altronde il dialogo parte da una base di condivisione, ed il confronto tra generazioni deve essere il preludio di una condivisione di spazi, valori, esperienze, memorie. I mattoni della società del futuro, per la quale si auspica una realtà diversa e decisamente migliore di quella attuale, possono essere più solidi se realizzati con la base dell’esperienza degli anziani, le risorse dei genitori e l’innovazione dei giovani.
Costruire il futuro: tempo e volontà
Se si pensa al tempo come un valore fondamentale, così come dovrebbe essere, si può considerare quale valore svuotato del proprio senso originario. La frase che probabilmente tutti dicono almeno una volta al giorno è “non ho tempo”; in pratica non si ha più tempo per i familiari, gli amici, la società. Non si ha più tempo per l’ascolto ed il confronto.
Questa condizione porta a vivere l’attimo e questo rende difficile il rapporto con il passato. Da qui nasce la difficoltà di comunicazione tra le generazioni ed è proprio sul concetto di “avere tempo” che bisogna lavorare. Il tempo di ascoltare, ma anche il tempo da dedicare al racconto, è un tempo che va preso e ricavato come in agenda si segnano gli impegni della giornata. Così come ci si ritaglia del tempo per dedicarsi alla lettura di un libro, allo stesso modo serve tempo per l’ascolto e per il racconto. A differenza di un libro però, il racconto delle generazioni precedenti non può aver luogo in solitudine, ma c’è bisogno appunto di interlocuzione e confronto.
A cosa serve questo tempo? All’ascolto ed al racconto ma non solo. La condivisione aiuta a stimolare momenti di analisi e riflessione interiore, momenti che risultano preziosi per valutare le azioni compiute e gli obiettivi da perseguire. Con queste premesse pare evidente che il dialogo intergenerazionale possa essere fondamento per la costruzione del futuro. Tempo e volontà sono fondamentali. Partendo dal racconto storico, del passato e cercando di spiegare ai giovani la volontà che ha spinto i giovani del passato ad intraprendere scelte coraggiose come quella di rifiutare la guerra, armarsi per liberare il proprio popolo, o scendere in piazza per i propri diritti. Laddove serpeggia lo scoramento, il “tanto non cambierà mai nulla”, bisogna lavorare sulla Memoria di quelle battaglie, fatte per il desiderio della verità e l’aspirazione della libertà.
Due valori per i quali è fondamentale battersi, perché non solo vanno a braccetto, ma costituiscono una forza impenetrabile che può piegare qualsiasi autoritarismo passato o futuro.